Un cane scodinzola felice mentre viene portato a passeggio, su una panchina c’è un uomo dallo sguardo malinconico, mentre un automobilista al semaforo sbuffa con impazienza.
Ogni giorno della nostra vita siamo immersi nelle emozioni, in un flusso di informazioni, sensazioni e stati d’animo che scambiamo con gli altri in modo costante. In un solo attimo, la capacità di cogliere le emozioni altrui ci apre una finestra sul mondo interno di perfetti sconosciuti, illuminando degli spazi altrimenti destinati a rimanere inaccessibili e segreti.
Da un punto di vista evolutivo, la capacità di capire il nostro prossimo, di riconoscere e condividere le sue emozioni e i suoi bisogni risulta fondamentale per la sopravvivenza e l’adattamento, ed è alla base della vita sociale.
Ma come riusciamo a comprendere le emozioni degli altri in modo così spontaneo e automatico, senza aver bisogno più di tanto di riflettere o di ragionare?

I neuroni dell’empatia
Qualche anno fa, un’équipe di scienziati italiani ha contribuito a rispondere a questa domanda grazie alla scoperta dei neuroni specchio. Le loro ricerche hanno mostrato che all’interno del nostro cervello esistono speciali reti di neuroni dotati di proprietà sorprendenti e mai osservate prima, in grado di dirci molto sul modo in cui riusciamo a comprendere le emozioni e a entrare in empatia con gli altri. I neuroni specchio si attivano sia quando compiamo, sia quando osserviamo un’azione diretta ad un oggetto, in modo tale che ogni atto osservato viene simulato internamente.
Facendo corrispondere la rappresentazione motoria di una data azione osservata con quella di un’azione eseguita, si viene a creare una specie di “vocabolario implicito” che permette il riconoscimento e la comprensione delle azioni degli altri in modo automatico, diretto e senza bisogno di una mediazione riflessiva (Gallese et al., 1996).
In modo simile, anche le emozioni mostrano caratteristiche espressioni facciali, con una configurazione dei muscoli che di fatto costituisce un’azione.
Partendo da tale presupposto, è stato ipotizzato che il meccanismo dei neuroni specchio possa abilitare una forma di comprensione diretta anche nel caso delle emozioni altrui, così come avviene per le azioni in generale.
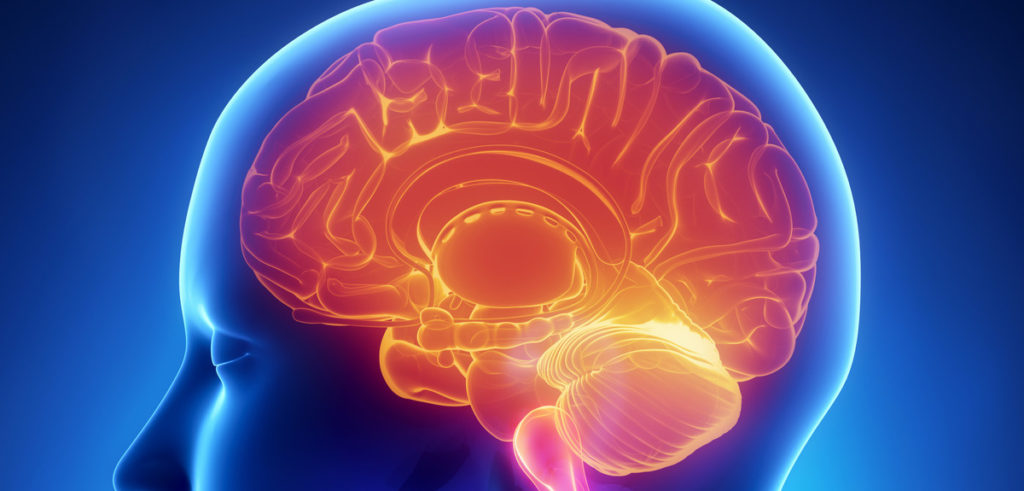
Sulla base di ulteriori evidenze, Gallese e colleghi (2004) hanno proposto una teoria neurale unificante per spiegare come gli individui comprendano le azioni e le emozioni degli altri: l’attivazione del sistema dei neuroni specchio produrrebbe una simulazione automatica della componente motoria delle espressioni facciali, collegata a sua volta con i centri viscero-motori responsabili degli stati somatosensoriali, limbici e viscerali che caratterizzano le esperienze emotive.
Tutto ciò ricreerebbe nell’osservatore l’esperienza dell’emozione altrui proprio come se la stesse provando in prima persona, permettendogli di riconoscere e comprendere le emozioni in modo diretto e senza bisogno di un esplicito ragionamento concettuale.
È stato affermato che questo meccanismo sarebbe fondamentale per l’intersoggettività e che potrebbe essere alla base dell’empatia, un’abilità preziosa sia nella vita relazionale sia nelle professioni d’aiuto, che consiste nell’entrare in risonanza con le emozioni degli altri.
Ma all’interno di questa teoria affascinante e suggestiva ci sono passaggi da chiarire e questioni ancora aperte, che è bene affrontare per evitare di cadere in ambiguità, semplificazioni e generalizzazioni non sufficientemente supportate dalle evidenze.
È accaduto spesso infatti che giornali e TV si siano occupati dei neuroni specchio in modo superficiale e sensazionalistico, amplificando il senso e la portata delle numerose scoperte fatte in questo campo.
Anche in ambito scientifico a volte emerge l’idea che il meccanismo dei neuroni specchio sia sufficiente da solo a spiegare il modo in cui comprendiamo le emozioni ed entriamo in empatia con gli altri. Di seguito vedremo perché non è del tutto possibile condividere questa affermazione.

Dai gesti alle emozioni
Nel caso delle azioni è stato affermato che i neuroni specchio non codificano solo un atto motorio, bensì una rappresentazione di tipo più astratto come il suo “scopo motorio” o “l’intenzione che l’ha motivato” (Rizzolatti e Fabbri- Destro, 2008).
La simulazione di questi specifici stati interni però non è applicabile al caso delle espressioni facciali di emozioni, che difficilmente possono essere equiparate a degli atti motori intenzionali. Le uniche espressioni facciali di emozioni che possono avvicinarsi a delle azioni intenzionali sono quelle simulate, diverse da quelle genuine perché mostrano pattern motori e temporali diversi.
Rispecchiamento di emozioni non genuine
Come si comporta il sistema specchio nel caso in cui si osservi l’espressione di un’emozione “falsa”, ovvero intenzionalmente simulata?
È in grado di riprodurre in chi la osserva lo stesso stato emotivo della persona che sta fingendo quell’emozione? In tal caso, produrrebbe un’emozione attenuata, diversa, oppure nessuna emozione? Di conseguenza, il sistema specchio può essere in qualche modo “ingannato” dall’espressione facciale di un’emozione non genuina?
Le emozioni “false” sono asimmetriche, più lente a manifestarsi nella loro sequenza motoria e quindi più durature rispetto a quelle autentiche. Le emozioni genuine invece coinvolgono un insieme di muscoli facciali particolari, difficilmente controllabili in modo volontario (Ekman, 1995). Esistono infatti delle micro-espressioni che possono permetterci di distinguere tra le manifestazioni di emozioni autentiche e quelle appositamente simulate.
In genere sono molto difficili da cogliere in quanto durano meno di un secondo, ma diventa possibile percepirle dopo un lungo e specifico addestramento.
Tutto ciò suggerisce però che i neuroni specchio, in condizioni normali, non contribuiscano più di tanto alla distinzione tra le emozioni genuine e quelle prodotte in modo intenzionale. Capirne il perché potrebbe far luce sui meccanismi della menzogna, un fenomeno psicosociale tanto complesso quanto controverso.

Provare un’emozione vuol dire anche comprenderla?
Secondo le teorie più accreditate e diffuse, una volta che un’espressione facciale emotiva sia stata simulata internamente, e quindi riprodotta nell’osservatore grazie ai neuroni specchio, quest’ultimo dovrebbe provare l’emozione osservata come se egli stesso la stesse vivendo in prima persona, e di conseguenza riuscire a comprenderla in modo rapido e diretto.
Ma anche se osservare, rispecchiare ed esperire un’emozione altrui equivalesse a provarla in prima persona, il problema è a monte: è già la stessa esperienza soggettiva di un’emozione che non garantisce di per sé di saperla riconoscere, comprendere o definire con precisione.
È esperienza comune non essere a volte consapevoli di un’emozione o non riuscire a etichettarla nel momento stesso in cui la si sperimenta. In alcuni casi si può riuscire a ricostruire a posteriori, magari dopo un certo tempo, l’esatta sensazione provata in quel determinato momento. Esiste anche un vero e proprio deficit della competenza emotiva ed emozionale, chiamato alessitimia, che si traduce nell’incapacità di mentalizzare, percepire, riconoscere e descrivere verbalmente i propri e gli altrui stati emotivi.
Quindi, se già il fatto di poter riconoscere l’emozione che si sta provando in prima persona non è ovvio né automatico, allora sarà ancor meno facile e scontato nel caso in cui l’emozione provata non sia originata internamente, ma scaturisca da una simulazione interna provocata dall’osservazione di un’emozione altrui.
Indagare le condizioni che facilitano o impediscono la comprensione delle emozioni proprie e degli altri, magari chiarendo il ruolo specifico dei neuroni specchio, potrebbe avere quindi numerose applicazioni terapeutiche nell’ambito dei disturbi della regolazione affettiva.

Influenze top-down nella simulazione dei neuroni specchio
L’idea che il sistema specchio di un osservatore riproduca le emozioni altrui in modo rapido e automatico è supportata da diverse evidenze, ma se un meccanismo del genere agisse in modo spontaneo e senza controllo saremmo continuamente in balia delle emozioni degli altri, e questo sarebbe ben poco utile e adattivo. Ad un qualche livello della simulazione interna infatti intervengono delle modulazioni di tipo top-down, basate su informazioni semantiche, episodiche e contestuali.
Numerose ricerche hanno dimostrato come il grado di rispecchiamento del dolore altrui può essere influenzato da fattori quali l’atteggiamento emozionale verso il soggetto osservato, l’esperienza di chi empatizza, informazioni contestuali rilevanti e l’assunzione o meno della prospettiva altrui. Vedere degli aghi infilati in un braccio causa sensazioni diverse, se ad osservarli è una persona qualunque o un agopuntore esperto.
Quindi il meccanismo specchio può essere certamente rapido, automatico e pre-riflessivo, ma comunque sembra essere influenzato da informazioni, processi e funzioni superiori di tipo contestuale e valutativo, siano essi consapevoli o meno.
A che punto intervengono queste modulazioni top-down? Interferiscono con l’automatismo del sistema specchio oppure agiscono solo in un momento successivo? Le risposte a queste domande permetteranno di comprendere meglio i meccanismi di funzionamento dell’empatia, in particolare cosa la favorisce o la inibisce, con ricadute importanti sul miglioramento della comunicazione e della relazione terapeutica per tutti coloro che lavorano nell’ambito delle professioni d’aiuto.

La comprensione di emozioni sociali
Le ricerche sui neuroni specchio per il momento si sono limitate a studiare l’emozione del disgusto e le sensazioni dolorose, mantenendosi quindi nell’ambito delle emozioni cosiddette di base, o primarie. Queste sono per definizione “semplici”, in quanto processi affettivi generati da sistemi cerebrali evolutivamente antichi, e hanno espressioni facciali innate e universali.
Esiste però un’altra tipologia di emozioni, strettamente collegate alla nostra capacità di interpretare e valutare stimoli sociali complessi. L’imbarazzo, l’orgoglio, il senso di colpa sono esempi di emozioni complesse, dette anche “riflessive” o “dell’autoconsapevolezza”, caratterizzate da espressioni facciali meno “tipiche” rispetto alle emozioni di base e più suscettibili di variazioni e sfumature. Queste emozioni per essere comprese possono richiedere la conoscenza, l’analisi e l’integrazione di molteplici elementi del contesto, l’accesso a contenuti mentali specifici e l’utilizzo di competenze cognitive come la valutazione di scopi, obiettivi e motivazioni della persona osservata. Il riconoscimento e la comprensione di questo tipo di emozioni non è possibile sulla base della sola espressione facciale, di conseguenza lo specifico contributo del sistema specchio a questo scopo può essere utile, ma non sufficiente.
Nel caso delle emozioni più complesse e sociali sono importanti quindi molti altri meccanismi oltre al sistema specchio. La buona notizia è che probabilmente si tratta di competenze che possiamo apprendere e sviluppare, suscettibili di modulazione e di controllo da parte dell’esperienza e del ragionamento riflessivo.
Capire come avviene la comprensione delle emozioni più complesse e sociali farebbe anche luce sul modo in cui si integrano le aree limbiche, evolutivamente più primitive, e quelle più recenti, plasmabili dalla cultura e dai processi di apprendimento.

Questo articolo è apparso originariamente sulla rivista “Psicologia Contemporanea” n° 228, a pp. 52-55, con il titolo “Emozioni allo specchio: i neuroni dell’empatia”.
Riferimenti bibliografici
Ekman P. (1995), I volti della menzogna, Giunti, Firenze.
Gallese V., Fadiga L., Fogassi L., Rizzolatti G. (1996), «Action recognition in the premotor cortex», Brain, 119 (2), 593-609.
Gallese V., Keysers C., Rizzolatti G. (2004), «A unifying view of the basis of social cognition», Trends in Cognitive Sciences, 8 (9), 396-403.
Rizzolatti G., Fabbri-Destro M. (2008), «The mirror system and its role in social cognition», Current Opinion in Neurobiology,
18 (2), 179-184.
